Intervista a Roberto Franchini, autore di “Cartoline da Auschwitz” e “L’ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti”
Dopo più di dieci anni dalla pubblicazione del breve, ma intenso libro intitolato Cartoline da Auschwitz, Roberto Franchini pubblica un volume dal titolo L’ultima nota, tornando sulla stessa tematica, cioè quella della Shoah, ma analizzandola da un’angolazione nuova e insolita, decidendo quindi di puntare su una trattazione di natura completamente diversa.
Nel primo caso, egli offre al lettore, sotto forma di testi di cartoline, spunti di riflessione con i quali il lettore potrebbe prolungare all’infinito la raccolta delle cartoline. Il libro ruota attorno all’interrogativo se sia giusto dare immagini al progetto di sterminio nazista, questione che ha diviso lungamente due fronti inconciliabili. Da una parte la ferma posizione del regista francese Claude Lanzmann, autore del documentario Shoah, che ha scelto di affrontare l’argomento senza mostrare mai le immagini dell’orrore, ritenendo che Auschwitz non abbia bisogno di immagini per essere spiegata, dall’altra il filosofo Georges Didi-Huberman, che nella sua opera intitolata Immagini malgrado tutto, ha sostenuto la necessità di mostrare, “nonostante tutto”, ciò che per gli aguzzini stessi doveva restare senza immagini e senza parole. «Da che parte sta, questo libro di cartoline dimezzate?», si chiede Michele Smargiassi nella nota che introduttiva.
Oggi, a due anni dalla ripubblicazione dell’opera in formato digitale, chiediamo all’autore, cosa ha significato ripercorrere il tragitto della morte vestendo i panni di un qualsiasi viaggiatore?
Si è soliti dire che il viaggiatore non è un turista, e viceversa (ovviamente). Già all’ingresso del lager di Auschwitz, nella biglietteria, mi sono accorto che il confine tra le due esperienze non è impossibile da attraversare. E, come tutti i confini, i due modi di viaggiare, di conoscere, di fare incontri, di fermarsi per guardare e pensare, sono porosi, sono innegabilmente a stretta vicinanza. I confini dividono ma sono anche una linea sola che unisce. Era la prima volta che andavo ad Auschwitz e a Birkenau e non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo cosa mi attendesse. I due lager attendono ciò che noi siamo e fanno emergere il meglio e il peggio di noi stessi. Anche quando tentiamo di resistere, di sottrarci, quando cerchiamo di alzare un muro di indifferenza per non venire travolti dal dolore.
Io ho cercato di non diventare un turista del dolore, appunto. Ma anche farsi viaggiatore in un luogo di morte è tutt’altro che semplice perché un luogo, ricostruito o mantenuto intatto “come se”, ha una patina di falso. Di parco a tema. E i parchi a tema di solito sono fatti per far divertire, non per pensare.
Parallelamente, i musei quasi sempre insegnano ma non coinvolgono la testa e il cuore dei visitatori. Una eccezione forse è il percorso pensato e allestito all’interno della fabbrica di Oskar Schindler a Cracovia.
Nel corso degli anni, di Auschwitz abbiamo sentito parlare sempre più di frequente, in alcuni casi l’interesse è stato talmente morboso da provocare una vera e propria “overdose di immagini”, diffuse in maniera a volte capillare da confondere spesso il pubblico meno preparato, che si è trovato come ad assistere anche passivamente a una sorta di “pornografia della morte”.
Auschwitz è diventata una meta di pellegrinaggio, un luogo di curiosità e di attrazione per l’enorme e distorta risonanza che molto spesso è stata data dal circuito mediatico. La messa in atto di questo processo, sviluppatosi soprattutto negli ultimi decenni, ha provocato l’effetto contrario: anziché sensibilizzare e aumentare la consapevolezza di quanto è accaduto, tra le altre cose, ha intrappolato in un unico ed emblematico luogo la storia della persecuzione e della deportazione e le singole storie che si sono consumate in quei terribili anni. Perdendo di vista il vero scopo del “fare memoria”, oggi sembra quasi normale visitare Auschwitz cercando di portare a casa un pezzo del campo: una foto, un sassolino, un ricordo tangibile di quanto visitato.
L’autore delle cartoline ci restituisce una visita di sole parole, senza immagini «perché Franchini è un uomo che assegna alla parola il diritto, che probabilmente possiede, di giudicare le immagini (di cui è un colto lettore); ma non concede il viceversa. Perché ritiene, ed anche questo è probabilmente vero, che le parole possano sviluppare ogni negativo del reale in un positivo del pensiero, mentre le immagini, a un certo punto, si fermano».
Quindi proseguiamo nel nostro incontro con Roberto Franchini. Nel viaggio che ha ispirato la scrittura delle cartoline lei ha scelto di non scattare neppure una foto, o le foto sono state scattate ma ha scelto di non mostrarle?
In realtà, ho scattato foto con il mio vecchio smartphone, ma non avevo intenzione di pubblicarle, di farne un libro o di utilizzarle come illustrazioni. Ho scattato foto come se il mio telefonino fosse un taccuino degli appunti. Anche solo per ricordarmi il nome di un bambino o le scritte sulle valigie ammonticchiate o i numeri allineati su un cartello.
Diverso lo scenario della sua recente pubblicazione dal titolo L’ultima nota, in cui affronta lo stesso delicato tema della Shoah optando per una trattazione più specifica. Infatti, qui analizza un aspetto insolito e indagato più raramente: la presenza e il ruolo della musica nei campi di concentramento e di stermino nazista. Cosa l’ha spinta ad occuparsi della presenza della musica nei campi, e che tipo di ricerca questo lavoro ha comportato?
Neppure io sapevo quanto la musica fosse protagonista nella vita di molti lager. È stato il caso a mettermi sotto gli occhi, in un breve arco di tempo, vicende e protagonisti tra loro assai distanti: Olivier Messiaen e il Quartetto per la fine del mondo, il violoncellista modenese Giuseppe Selmi, l’esperienza dei Ghetto Swingers a Terezin, l’orchestra femminile di Birkenau e la sua direttrice Alma Rosé, le notazioni di Etty Hillesum sul campo di transito di Westerbork (nei Diari e nelle Lettere). Li ho incontrati lavorando ad altri libri. Il caso voleva suggerirmi qualcosa e io ho ascoltato il suggerimento. Ho cercato libri (memoir, saggi, ricerche, testimonianze), ho ascoltato molta musica, ho navigato in rete selezionando i siti web più affidabili e più ricchi di materiali, ho guardato fotografie, disegni e video.
Nella parte iniziale del libro, si pone un duplice interrogativo: com’era possibile che degli assassini fossero tanto sensibili all’arte e soprattutto alla musica? Com’era possibile anche solo immaginare che in quei luoghi, dove era spenta ogni piccola luce di umanità, fosse rimasta viva a lungo la musica?
La risposta la fornisce soprattutto la figura del carnefice, figura determinante nell’assetto e nell’organizzazione delle varie operazioni che ad essa competevano, si trattava di uomini che racchiudevano una complessità di aspetti spesso controversi e comportamenti inspiegabili, figure di cui, con parole chiare ed efficaci, ci fornisce un’idea precisa: «Gli assassini sedevano in prima fila ad ascoltare orchestre e cantanti. Si commuovevano fino alle lacrime. Poi riempivano i treni e le camere a gas di prigionieri senza mostrare alcun sentimento».
È possibile che potessero coabitare nella stessa persona delle emozioni così contrastanti, oppure è più lecito pensare che gli stessi carnefici fossero in qualche modo vittime di un sistema che li ha prima spogliati di ogni umanità e poi costretti ad essere dei freddi esecutori di ordini?
Confesso di non avere una risposta solida a questa domanda. Dobbiamo partire dalla realtà e la realtà è quella che lei ha descritto: nel mio libro porto molte testimonianze sull’atteggiamento degli ufficiali. Nei fatti assistiamo ad uno sdoppiamento della personalità: era il ruolo che faceva il comportamento. Amanti della musica nel tempo libero e esecutori di ordini nel ruolo di comandanti. Se, poi, il ruolo imponeva loro di costituire orchestre, di far eseguire musica per scandire i tempi di vita e di lavoro nei lager, di portare piacere alla vita infernale delle guardie tanto meglio. Ma non era l’amore per la musica che li portò a incentivare le attività musicali. Se anche tutto ciò ha spinto molti musicisti a piegarsi ai voleri delle SS, io non credo che fosse questa la strategia pianificata a tavolino dalle SS: annullare ogni differenza morale tra aguzzini e vittime è un risultato della realtà, non è il frutto di un progetto politico e culturale dei nazisti.
Le descrizioni, così come le informazioni che ci ha fornito, sono molto dettagliate e approfondite, fanno comprendere chi erano i musicisti, scoprire la qualità delle loro composizioni e delle loro esecuzioni, come si formavano le orchestre, i cori, i vari gruppi che si esibivano. Durante la lettura è sempre più evidente che quasi in tutti i campi di concentramento la presenza della musica era un elemento quasi connaturato alla permanenza stessa dei prigionieri in quei luoghi. La musica era richiesta non solo per allietare le SS e gli altri organi dirigenti del campo, ma anche per scandire diversi momenti, soprattutto i più drammatici della giornata per i prigionieri. La musica, elemento vitale, era anche accompagnamento della morte. «La musica aveva un potere penetrante. […] Veniva usata anche durante gli interrogatori e le torture mescolandosi alle urla dei tormentati» scrive, sottolineando la mostruosità insita nel progetto nazista anche nell’usare la musica come tortura psicologica dei prigionieri. «Esisteva anche il canto a comando, i detenuti ricevevano l’ordine di intonare una canzone, tenendo il tempo, che era un tempo militare. Erano occasioni in cui i prigionieri venivano scherniti e derisi».
La seguente domanda, che pongo anche a me stessa, in quanto studiosa della Shoah nei suoi aspetti rappresentativi, è questa: come si fa a conservare sempre una base di distacco e lucidità nel descrivere alcuni momenti della vita dei campi con esattezza e con una modalità di ricerca puntuale e dettagliata, quando sarebbe più naturale farsi trascinare da una sofferente incredulità?
Anche io ho iniziato la mia ricerca storica, partendo da una base di sofferente incredulità. Il lavoro di ricerca deve ricercare, non avere conferme ad un assunto predeterminato. Il che non toglie la necessità parallela di muovere da posizioni etiche.
Ancora, Lei osserva che le canzoni nel lager sono state oggetto di dibattito e di scontro tra i sopravvissuti e tra gli studiosi, e a questo proposito cita una significativa frase di Primo Levi: «Esse giacciono incise nelle nostre menti, saranno l’ultima cosa del lager che dimenticheremo». Questa osservazione fa riflettere su uno degli elementi scarsamente considerato, soprattutto nelle restituzioni narrative che sono state spesso proposte come strumento di conoscenza della Shoah. Non potremmo avere un quadro completo di ciò che è stata quest’enorme tragedia senza riflettere sull’importanza che invece ha avuto la componente musicale in genere nello scandire le giornate di lavoro, le uccisioni e le torture, gli arrivi e le partenze dai campi. Certamente ha rappresentato anche dei momenti di svago e una delle possibilità per evadere da una situazione drammatica, e più di una volta ha rappresentato lo scampare alla morte e la salvezza, soprattutto per chi possedeva la capacità di suonare uno strumento.
Le sue due pubblicazioni ci fanno compiere due viaggi, il primo più introspettivo, che lascia al lettore la possibilità di completare quei brevi testi soprattutto con un lavoro di immaginazione e di riflessione, ambientato nei resti del campo musealizzato e quasi “esibito” al pubblico, il secondo mette il lettore di fronte ad una scoperta sconcertante nell’apprendere come fosse possibile che in un luogo destinato alla sofferenza più inaudita, esistesse una dimensione così surreale, in cui degli esseri umani fossero capaci di conservare e custodire a tutti i costi la propria identità, in nome della passione che li spingeva a vivere e ad andare avanti “malgrado tutto”. È questo il vero scopo del libro?
No, mi dispiace, non è esattamente questo il vero scopo del libro: io ho tentato di mettere sotto gli occhi delle persone interessate e sensibili un tema. Che è però anche un problema. E il problema a me pare di non facile soluzione: la musica era pena o sollievo? Lo era per i soli musicisti o anche per i prigionieri? La musica era sollievo anche per le guardie e per i militari (che questo fosse lo scopo intenzionale ad Auschwitz, per esempio, è certo). La posizione di Primo Levi è autorevole ma non va accolta senza sottoporla ad analisi critica. Il mio libro testimonia che i musicisti potevano essere anche odiati e insultati (è il caso, per esempio, delle componenti dell’orchestra femminile di Birkenau) ma anche amati, e in questo caso le testimonianze sono molteplici. Per gli strumentisti e per molti dei prigionieri la musica era sollievo ed era un’arma in più per resistere, per “non morire dentro”. Per non perdere la speranza. Dopodiché, la vita e la morte non erano il premio o la punizione per chi suonava: erano i comandanti a decidere chi sarebbe andato a morire.
Io amo ripetere la definizione attribuita a Thomas Mann secondo la quale sotto il nazismo la Grande Bellezza si alleò con il Grande Diavolo. Che è una descrizione, non una interpretazione. Resta il fatto che la musica non salvò il mondo e tantomeno la vita di tanti prigionieri nei lager.
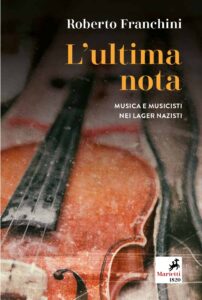
L’ultima nota. Musica e musicisti nei lager nazisti, Marietti, pp. 328, 24 euro

Cartoline da Auschwitz, Marietti, pp.46, formato ebook, 2,99 euro

