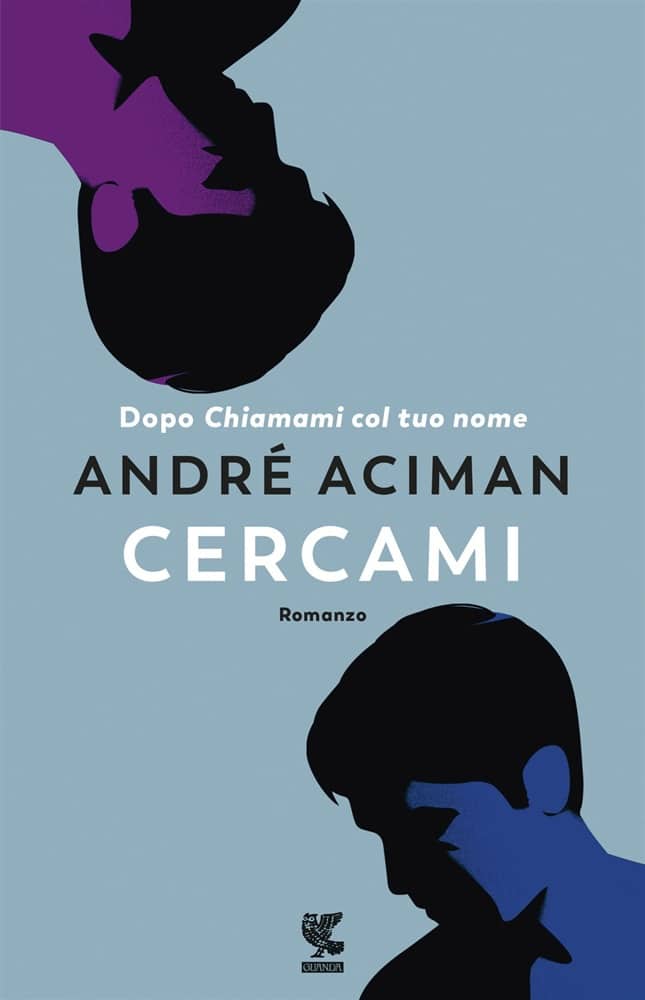
La parola amore qui è usata (quasi) a sproposito. Come morte: un errore, secondo lo scrittore. E Dio? Si svela in questo questo dialogo con l’autore
Quattro storie, quattro amori, quattro città: linee che si intersecano oppure, se si vuole, un cerchio che aspira a chiudersi. Ecco Cercami, l’ultimo romanzo di André Aciman, appena pubblicato da Guanda per la collana “Narratori della Fenice” nella traduzione di Valeria Bastia. Ogni vicenda di Cercami è il prolungamento di un’altra: oppure un richiamo, un’evocazione, un portare avanti una promessa. Su un’onda che fa danzare situazioni nuove e volti conosciuti, quelli di Chiamami col tuo nome. Il tutto, lungo un “filo conduttore ebraico che corre attraverso le vite” (secondo un’espressione propria del libro), che si snoda con discrezione eppure costante presenza, passando dall’essere dissimulato, coglibile solo a una lettura molto attenta, al rivelarsi in modo via via sempre più determinante. Tempo, amore e identità corrono lungo questo filo, pervaso dalla memoria e da un sentimento tutto particolare, lo struggimento per la vita incompiuta e la tensione verso un prolungamento della stessa. Ne parliamo in questa intervista con l’autore.
Vorrei partire dal secondo racconto, in particolare dal riferimento al Kol Nidré, il brano che apre lo Yom Kippur e segna un nuovo inizio, ma tiene conto del passato. Quasi a sancire la concezione del tempo nel romanzo: un tempo ebraico, lineare e ciclico contemporaneamente.
“L’immagine più consona al “tempo ebraico”, più che il ciclo, per me è la spirale: tutto si ripete, le belle cose e le catastrofi, e soprattutto di queste ultime è importante onorare la memoria, in un modo o nell’altro. Era molto importante per me che il libro si svolgesse lungo un filo conduttore ebraico, per quanto esso si riveli in modo sottile”.
E le storie d’amore del libro hanno una qualche “connotazione ebraica?”
“Non credo che l’amore romantico sia vissuto in modo diverso nell’ebraismo rispetto ad altri credi. La connotazione ebraica si trova piuttosto nella narrazione del rapporto tra padre e figlio: un amore tremendo e potente, molto importante e problematico nella storia ebraica. A partire da Abramo, che ama moltissimo il figlio, ma è anche disposto a ucciderlo. Questo sentimento così forte viene trasmesso attraverso le generazioni: ma non è solo l’amore che si passa ai figli. Si trasmettono anche le cose che non sono state realizzate. La vita incompiuta è forse il tema più importante del romanzo. Riguarda l’incapacità di accettare che la vita finisca: l’unico modo di impedirlo è trasmettere questa vita al figlio, perché la compia in un modo o nell’altro”.
“Compiere” nel senso di portare avanti, non di completare.
“Certamente. Portare avanti è l’unica cosa che si possa fare. Nel primo racconto, ad esempio, c’è la narrazione del grandissimo amore tra Miranda e suo padre, che si trova sul finire della vita. E c’è questa frase emblematica: “Voglio che vivrà dopo di me prolunghi la mia vita, non solo che la ricordi”. Penso che questa sia un’idea fondamentalmente ebraica. Secondo il padre di Miranda, la vita è un grandissimo sbaglio e in ciò che ci è dato bisogna cercare di trascenderne i limiti”.
Un desiderio che contiene dell’angoscia?
“Chiaro, perché la morte è la cosa più angosciosa che ci possa essere. E la morte secondo me è un grandissimo sbaglio”.
Come la vita?
“No, la vita non è sbagliata. Ma lo diventa se la sua conclusione è la morte. Per me non dovrebbe esistere”.
Il prolungare la vita attraverso gli altri è quindi l’unico modo per “aggirare l’ostacolo”?
“Sì, insieme a un’altra via di fuga: l’arte. Anche di questo si parla nel libro. È l’unico altro modo di trascendere e completare la vita”.
Torniamo al sottile filo conduttore ebraico: è presente fin dall’inizio, ma devono passare molte pagine prima che si riveli esplicitamente.
“Sì, è vero. Io non sono praticante, per nulla. Non desidero esserlo e non l’ho trasmesso ai miei figli, così come mio padre ha fatto con me. Ma mi considero ebreo, faccio parte di questa linea che va a finire oltre cinquemila anni fa. E credo che ci si debba accostare con umiltà alla millenaria storia di un popolo che viene perseguitato e trascende tutti i limiti per sopravvivere. E non c’è solo la sopravvivenza, ma anche l’ironia: l’ironia profonda che bisogna mantenere nel cuore, perché altrimenti niente ha senso. Dio stesso, se esiste, ha un profondo senso dell’ironia. Se non si capisce l’ironia non si può essere ebrei”.
Lei è un grande esperto dell’opera di Proust: quanto c’è di lui nella sua scrittura?
“Proust mi ha influenzato molto. In Proust c’è ironia, ma soprattutto c’è bontà: una bontà rapsodica, verso la madre (che forse non ha mai amato), verso la nonna, verso gli altri. Un sentimento profondo e indimenticabile di umanità che pervade tutta la sua opera: non pietà, ma empatia, anche quando esprime negatività. Proust esamina tutti, senza scampo, in modo irrevocabile, ma allo stesso tempo li perdona. Ha questo miscuglio di ironia profonda e, in contrasto, quasi di cattiveria, gusto del pettegolezzo, in cui però l’umanità non viene mai a mancare. Questa combinazione così particolare mi ha certamente influenzato. Anche se a pensarci bene non ci sono cattivi veri e propri nella mia opera”.
Scriverebbe un libro con un antagonista, un “cattivo” propriamente detto?
“Impossibile. Perché non mi interessa. La cattiveria ce l’ho anch’io nell’animo, come tutti, ma non mi piace esaminarla e nemmeno esibirla. La voglio nascondere: preferisco un amore falso alla cattiveria”.
Possiamo dire che nel libro l’amore sia il veicolo per parlare di identità?
“La parola amore mi dà molto fastidio”.
Come definire allora le relazioni tra i personaggi?
“Il voler essere con un altro. Voler essere con questa persona e voler essere questa persona, purché questa persona voglia a sua volta essere con noi ed essere noi stessi. Uno scambio di identità: se vogliamo, chiamiamolo amore.”
Riprendiamo dunque l’idea di Chiamami col tuo nome. Ma perché la parola amore è sbagliata?
“Perché è allo stesso tempo impegnativa e superficiale. Se ci fa caso, gli stessi personaggi quando si dichiarano l’un l’altro i propri sentimenti la usano molto poco”.
A chi parla Cercami?
“Sembrerà strano, ma quando scrivo non penso mai ai lettori. Secondo me quando si scrive o comunque si compone un’opera d’arte – adesso, lo dico, ma non ci credo – si parla con Dio. Con un ideale di perfezione. La scrittura è un cercare di indirizzarsi a Dio. Perciò bisogna stare attenti a come gli si parla. Non si può scrivere in qualunque modo, in un “linguaggio da giornale”, perché a Dio non piace”.
C’è un legame tra l’idea di parlare con Dio e l’attenzione nei suoi libri alla descrizione della bellezza?
“Sì, la scrittura deve raccontare le cose come sono, ma anche sentirle, onorarne la bellezza. È come mandare un telegramma a Dio e dirgli “Ecco, sono qui, seduto in questo ristorante, e ti ringrazio”. Anche se non sono credente, questo è il modo per indirizzarsi a Dio al meglio che ci possa essere. E quando lo si fa, bisogna usare l’arte, il linguaggio più bello e più coerente. Altrimenti Dio non ci ascolta. Non ci fa neanche caso”.
Laureata a Milano in Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, ha studiato Peace & Conflict Studies presso l’International School dell’Università di Haifa, dove ha vissuto per un paio d’anni ed è stata attiva in diverse realtà locali di volontariato sui temi della mediazione, dell’educazione e dello sviluppo. Appassionata di natura, libri, musica, cucina.
