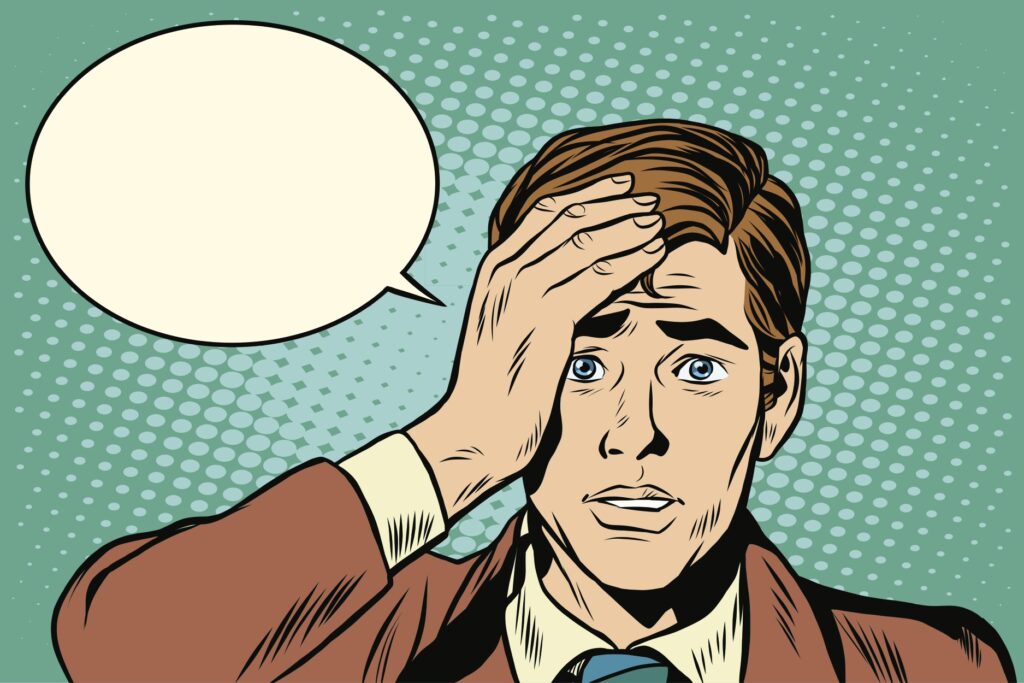
Intervista con la semiologa Valentina Pisanty
Prosegue il viaggio di Joimag nella parola memoria. Un termine dal significato molteplice, facilmente manipolabile, intrecciata alla sfera più intima di ognuno di noi. Qualcosa di vivo, un materiale incandescente come avevo già scritto, oppure qualosa di cristallizzato, reso immobile nella sua monumentalità. Ecco perché la memoria della Shoah è attualmente oggetto di polemiche e aspre discussioni all’interno della comunità ebraica, ma anche all’esterno, dove l’istituzione della Giornata della Memoria rischia di boicottarsi da sola: l’effetto disinteresse (se non addirittura noia) è da tempo in discussione. Gariwo con il suo presidente Gabriele Nissim ha lanciato una Carta della Memoria di cui abbiamo già parlato su queste pagine, sollevando un dibattito importante. E qui, su Joimag, dopo l’incontro con lo storico Simon Levis Sullam, ne parliamo con Valentina Pisanty, docente di semiologia all’Università di Bergamo, studiosa della Shoah, coordinatrice editoriale di Accepting Diversity, manuale interattivo sulla tolleranza nato da un progetto di Umberto Eco, Furio Colombo e Jacques Le Goff, è autrice, tra gli altri, del libro I Guardiani della memoria (Bompiani).
Partiamo dall’inizio: in che modo la semiotica indaga la memoria?
Siamo animali simbolici, biologicamente incompleti, che non sopravvivono fuori da ambienti saturi di segni e di rappresentazioni culturalmente registrate. Tra queste, le storie con cui ci rappresentiamo eventi passati e ne tramandiamo il ricordo alle generazioni future. La semiotica indaga i diversi modi in cui gli umani in generale, e le specifiche comunità culturali in particolare, attribuiscono senso al mondo, selezionano gli eventi ritenuti importanti e ne confezionano il ricordo, di volta in volta evidenziandone alcuni aspetti a scapito di altri, istituendo nessi causali tra i frammenti sparsi dell’esperienza, privilegiando alcune prospettive e formulando alcune interpretazioni utili – si suppone – alla comprensione non solo del passato ma anche del presente e, soprattutto, degli obiettivi futuri che la comunità si prefigge. Per la semiotica, la memoria è un dispositivo culturale di filtraggio e di montaggio dei ricordi ritenuti pertinenti, ovvero funzionali agli obiettivi e alle preoccupazioni dominanti di chi in quel momento ne detiene il controllo.
Perché memoria è una parola così controversa e difficile nel suo utilizzo? Occorre ridefinirla?
Perché la memoria è sempre di qualcuno che se ne sente il titolare e perciò ritiene di poterne fare l’uso che vuole. L’aspetto privato, proprietario della memoria (sia individuale, sia collettiva) non è un tratto accessorio, ma è proprio la caratteristica essenziale che definisce il funzionamento di ogni dispositivo commemorativo. Questo ricordo è mio (persino quando sbaglio e ricordo male come sono andate veramente le cose) e nessuno potrà mai togliermelo. Io sono la mia memoria e guai a chi me la tocca.
Ma mentre a livello individuale la piena titolarità del soggetto è inoppugnabile, quando si passa al ricordo culturale di eventi che riguardano l’intera comunità la questione si fa molto più complessa e controversa. Chi ha diritto di stabilire i formati della memoria (cosiddetta) collettiva, posto che gli eventi a cui questa memoria si riferisce coinvolgono più soggetti i cui ricordi non necessariamente coincidono – anzi, spesso confliggono radicalmente?
Specie per quanto riguarda il ricordo di eventi che ancora bruciano nel presente, ne deriva un’inevitabile guerra delle memorie che si contendono il ruolo di narrazioni culturalmente egemoni. Chi decide per tutti gli altri chi siamo “noi”, quali interpretazioni e ricordi meritano di essere conservati e quali invece di essere scartati o spinti in minoranza?
Pensare di risolvere questi conflitti restando sul piano esclusivo della memoria è velleitario: tutt’al più si potranno confinare ai margini della cultura le versioni sgradite per sostituirle con la propria. Con tutti gli effetti che ne scaturiscono, tra cui il risentimento represso di coloro che si sentono esclusi dalla narrazione dominante e che alla prima occasione faranno di tutto per ribaltare l’equilibrio a proprio favore.
La memoria della Shoah deve fare i conti con la storia e anche con la semiotica: perché questo confronto potrebbe evitare che la memoria si congeli pericolosamente nella sua sacralizzazione?
Da Tucidide in poi, il ruolo della storia è fornire un punto di vista “altro”, critico, sganciato dagli interessi dominanti di questa o di quell’altra comunità commemorante, per ricostruire la dinamica degli eventi nel modo più oggettivo possibile. A questo serve il metodo storiografico-documentario al quale, almeno in teoria, tutti gli storici (e più in generale tutti coloro che ragionano in modo scientifico-argomentativo) sono tenuti ad attenersi. Le regole del gioco storiografico – dimostrabilità, coerenza, esaustività ed economicità delle ipotesi interpretative – dovrebbero garantire un confronto equo tra punti di vista diversi, tale da restituire alla comunità intera una rappresentazione complessa, sfaccettata e mai definitiva di come sono andate veramente le cose.
La storia è pubblica laddove la memoria è privata. In linea di principio chiunque può partecipare alla discussione storica, purché sia disposto a dotarsi delle competenze necessarie e a sottoporre le proprie ipotesi al vaglio scientifico del resto della comunità. È l’esatto contrario della sacralizzazione, cioè dell’irrigidimento di una narrazione particolare e unilaterale in formati intoccabili, imposti dall’alto, gelosamente presidiati e protetti da una barriera invalicabile di tabù discorsivi. La sacralizzazione prescrive un atteggiamento passivo, ligio e conformista da parte della comunità commemorante, che delega ai “Guardiani della Memoria” – soggetti o istituzioni culturali preposti alla gestione dei riti commemorativi – il compito quasi sacerdotale di amministrare le pratiche idonee, di tenere fuori gli indesiderati e di istituire o autorizzare nessi rilevanti tra il passato e il presente.
Fare i conti con il “mai più”: la carta di Gariwo parla di un’universalizzazione del concetto per estendere quel mai più all’umanità intera. Cosa ne pensa?
Come formula rituale “Mai più” è foriera di molti equivoci. Significa troppe cose insieme, dalla difesa a oltranza dei diritti di un gruppo particolare (and never mind the rest) al generico auspicio di un futuro senza più vittime o discriminazioni. L’interpretazione universalizzante che ne dà la carta di Gariwo – mai più discriminazioni e persecuzioni ai danni di chicchessia – è senz’altro un proposito a cui mi sento di aderire. Consapevole, tuttavia, che a nessuno nella storia umana è dato o sarà dato di garantire che qualche cosa non succeda mai più. Ciò ovviamente non vuol dire che dobbiamo rinunciarci in partenza: la riduzione delle diseguaglianze e delle ingiustizie strutturali da cui l’intolleranza trae linfa è un obiettivo imprescindibile per chiunque prenda sul serio l’impegno di lottare contro ogni forma di razzismo e xenofobia.
Può il presente essere uno strumento per capire il passato e dunque per fare memoria?
La memoria è sempre radicata nel presente. Lo è in due sensi. Il primo, come dicevo, è che ciò che ricordiamo del passato dipende dai nostri interessi e dalle nostre preoccupazioni attuali. Il secondo è che il presente è uno tra i tanti esiti possibili delle condizioni create dal passato: la storia è andata così, ma forse sarebbe potuta andare diversamente. Uno sguardo retrospettivo (anche critico) può aiutare a capire quali scelte sono state fatte, quali sono state scartate, e perché. Come, in altre parole, siamo arrivati a questo punto? Quante decisioni abbiamo preso – o abbiamo lasciato che altri prendessero al posto nostro – senza neppure rendercene conto? Liberando il presente da una cappa di inevitabilità (è così perché non poteva andare diversamente) si può forse recuperare un senso di alternativa possibile, un margine di immaginazione politica, una responsabilità di scelta consapevole che è – mi sembra – ciò di cui maggiormente avvertiamo la mancanza nella fase culturalmente stagnante in cui oggi ci troviamo.
È nata a Milano nel 1973. Giornalista, autrice, spesso ghostwriter, lavora per il web e diverse testate cartacee.
