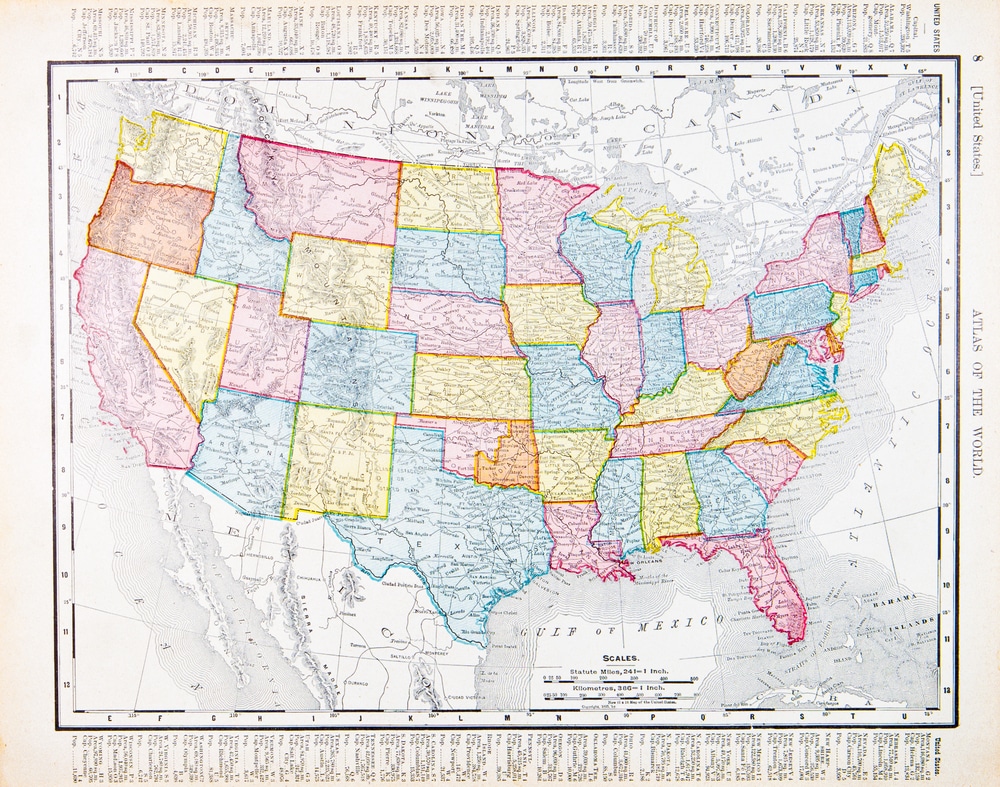
Gli Stati Uniti in bilico tra radicalismi di destra e continuità istituzionale. Analisi dell’immediata epoca post-Trump
Alla fine, Joe Biden è stato dichiarato «President elect» in base all’attribuzione di 290 grandi elettori, su una maggioranza necessaria di 270, di contro ai 214 invece riconosciuti al suo avversario. Gli americani, infatti, hanno concretamente votato per questi ultimi, come tali collegati ad uno dei due concorrenti. Il 14 dicembre, quindi, i grandi elettori si riuniranno in un collegio elettorale dove eleggeranno (definitivamente) il nuovo presidente e, con lui, il suo vice. Di fatto, quest’ultimo passaggio è la sanzione legittimante di un processo già consumatosi, attraverso il voto delle urne, ma che nel non semplice sistema elettorale americano richiede questi transiti.
Presidente in carica, tuttavia, è ancora Donald Trump, già candidato alla riconferma e da adesso, formalmente, presidente uscente. Le distinzioni non sono esercizi lessicali di rito, rispondendo semmai ad una precisa prassi che deriva dal sistema di garanzie costituzionali che gli Stati Uniti hanno adottato e consolidato nel tempo. In parole povere, ciò implica che si apra da adesso una fase intermedia, che durerà fino al giuramento del presidente eletto, il 20 gennaio 2021, quando solo allora sarà nel pieno possesso di tutti i poteri attribuiti alla sua funzione, entrando quindi definitivamente in carica. Questa fase di transizione, che si protrarrà per più di due mesi, sarà senz’altro delicata. Donald Trump ha infatti dichiarato ripetutamente di non volere riconoscere la vittoria del suo avversario. Facile immaginare che non faccia quindi seguire ad essa quegli atti e quei gesti, non solo di galateo costituzionale ma di continuità politica, che sono invece nella prassi del sistema istituzionale statunitense quando si transita da una presidenza all’altra. Plausibile quindi immaginare anche che, quando Biden dovesse accedere formalmente alla Casa Bianca, il presidente uscente non si faccia trovare, delegando – come alcuni già lasciano intendere – il suo vice a svolgere le funzioni di rito. Affinché ciò accada, tuttavia, dovrebbe lasciare l’ultimissimo scorcio della sua presidenza in mano a Mike Pence, in tutta verosimiglianza dimissionandosi.
È uno scenario, va ripetuto, che certuni configurano ma senz’altro da verificare, nella sua concreta realizzabilità, di qui alle settimane a venire. Un’ipotesi, quindi, non una certezza e neanche una probabilità. Di mezzo, ripetiamolo, ci sono comunque diversi passaggi. Donald Trump ha lasciato intendere da subito che non avrebbe accettato altra vittoria che non fosse la sua. In tale senso si è pertanto attrezzato, e da tempo. A seguito dei risultati elettorali, a lui sfavorevoli, ha quindi dichiarato che inizia ora un lungo excursus legale, per contestare i risultati del voto (e dello spoglio delle schede) in diversi Stati. Si tratta di una strategia legittima che, tuttavia, demanda ai giudici, statali e federali, a seconda del grado di giudizio chiamato in causa, l’ultima ed insindacabile parola. I primissimi pronunciamenti, ai quali seguiranno nelle settimane a venire gli esiti di molti altri ricorsi in via di istruzione, non sono comunque favorevoli alle sue richieste.
Il rimando sistematico ai “brogli” – peraltro – più che indicare una precisa strategia politica volta a identificare effettive alterazioni del processo elettorale, è semmai uno strumento per negoziare l’uscita di scena dalla White House, non solo rendendone più impegnativo l’ingresso al nuovo inquilino ma anche e soprattutto coalizzando i propri sostenitori intorno alla narrazione, in sé potentissima, della vittoria scippata. Già ci è capitato di scrivere che si tratta di un tema tipico delle destre radicali, che ricorre in tutto il Novecento e si riproduce oggi. Qualcosa del tipo: il popolo è stato ingannato e defraudato della sua manifestazione di volontà qualora essa non coincida con quella del leader populista. Trump si è consapevolmente candidato ad esserne un leader di area radicale, in sintonia con gli esponenti di una generazione politica cosiddetta “sovranista”, presente un po’ in tutto il mondo, che basa la sua legittimazione sia sull’accentuazione del carisma personale che sul rapporto diretto, senza intermediazioni istituzionali, tra sé e la collettività elettorale.
Il mantra della vittoria «tradita», «rubata», «scippata» verrà ripetuto a prescindere da qualsivoglia riscontro nel tempo a venire. Poiché si tratta del mito fondativo di una destra radicale che, da sempre, si rigenera affermando non di essere stata sconfitta poiché minoritaria ma di avere subito un defraudamento al quale si può porre rimedio in un unico modo, ossia perpetuando la delegittimazione della controparte vincitrice, che non avrebbe alcun diritto a governare perché intrinsecamente truffaldina. È un discorso che accompagna tutta la traiettoria delle molte destre illiberali del secolo trascorso e che si rinnova, adesso, dinanzi ai mutamenti delle società contemporanee, raccogliendo anche la scarsa o nulla propensione di una parte dell’elettorato alla mediazione istituzionale. La partecipazione ai processi elettorali, infatti, non si inscrive all’interno di una piena accettazione delle regole dell’alternanza bensì dentro una logica di mera auto-legittimazione, alla quale fare seguire l’espulsione dei contendenti e degli avversari dal novero del legittimo conflitto: chi non è con noi, è contro di noi, costituendo quindi una minaccia alla nostra stessa esistenza. La scarsa tolleranza per la dialettica democratica, alla quale si sostituisce un’altra retorica potente, quella dell’estromissione illegittima del «popolo» da parte dei «poteri forti», il combinato tra informazione, finanza ed élite culturali. Un substrato ideologico non certo inedito e proprio per questo facilmente sottoscrivibile, in quanto tradizione di lungo periodo, di cui il populismo è l’involucro più efficace.
Inutile contrapporre al piano delle affermazioni sul “grande furto”, la cui forza riposa nella loro ossessiva reiterazione, i riscontri della loro inconsistenza fattuale. Ciò che vanno cercando coloro che credono in essi, infatti, è un mito rigenerativo, trovandolo nel convincimento di avere comunque ragione e, proprio per ciò, di essere le vittime elettive di un complotto. Tutta la traiettoria di Donald Trump, dalla sua prima candidatura alle primarie repubblicane del 2015 ad oggi, è stata infarcita di rimandi all’immoralità di quanti non si comportassero secondo le sue richieste perentorie. A rischio, come è ripetutamente avvenuto, di gettare “giù dalla sella”, anche esponenti della sua stessa parte politica, trovandosi poi acerrimi avversari in alcuni dei suoi stessi iniziali sostenitori. L’arcipelago cospirazionista che ha avuto un ruolo nella raccolta dei voti, a partire da QAnon, testimonia di ciò, insieme al solidissimo sostegno evangelico, un vero e proprio circuito sub-culturale, prima ancora che politico, che da almeno la presidenza di Jimmy Carter entra di peso in gioco nell’orientamento di una parte delle preferenze elettorali. Il nesso tra sospetto ed atteggiamento paranoide, insieme ad un’immagine politica salvifica, quasi ispirata ad un messianismo laico, è il fuoco della visione delle cose sia in campo cospirazionista che, di riflesso, nel milieu evangelico.
A questo punto, tuttavia, ciò che dovrebbe essere oggetto di riflessioni a venire è la notevole capacità che Trump ha comunque manifestato di creare intorno alla sua figura, volutamente divisiva, un seguito elettorale molto diffuso, che non può essere liquidato come un fenomeno estemporaneo, ovvero occasionale. I risultati elettorali parlano da sé: a fronte della partecipazione record del 67% degli aventi diritto – un risultato di per sé storico negli Stati Uniti – se Joe Biden vince con 75.193.022 voti al momento certificati (pari al 50,6%), Trump lo tallona con 70.804.968 (il 47,7%). Posto che la percentuale residua dell’1,7% non assegnata ad uno dei due candidati va intesa come l’insieme dei voti nulli o attribuiti a candidati terzi, contemplando l’1,2% del Libertarian Party di Jo Jorgensen e lo 0,2% di Howie Hawkins del Green Party.
Un chiaro segno che Trump ha dato origine ad un fenomeno politico – se lo si vuole etichettare lo si potrà chiamare anche “trumpismo” – che fuoriesce dalla stessa tradizione repubblicana, altrimenti in chiara difficoltà di idee, ipotesi e proposte. Il presidente uscente, infatti, rimodella aspetti significativi della cultura politica conservatrice, alla quale ambisce a dare un nuovo volto. Il radicalismo di cui si è fatto depositario, ha incontrato i favori di una nutrita parte dell’elettorato, che si è già da tempo spostato su piattaforme più estreme, dove la forte identificazione emotiva con la leadership – quindi con la figura del “capo” – è un asse strategico. All’uscita di scena del presidente, quindi, non corrisponderà in alcun modo il declino e l’archiviazione di un serbatoio di pensieri, così come anche di emozioni che, invece, Donald Trump non ha solo legittimato ma costruito come una sorta di piattaforma di diffuse rivendicazioni. Da ripetere nel futuro poiché già da adesso è il vero involucro identitario della destra statunitense. Tempo comunque verrà, ed anche a breve, per indagare non solo sui contenuti di questo neopopulismo, con forti accenti suprematisti, ma anche e soprattutto sulla composizione dell’elettorato che già da tempo si è fidelizzato con questo comune sentire.
La contromossa democratica, con il ticket Biden-Harris, ha vinto ma non senza difficoltà. Nessuna “onda blu”, per intenderci, ma un lungo, defatigante scontro sul campo, voto dopo voto. Uno scenario diverso da quello che una parte degli analisti aveva invece ipotizzato e che ci dice molte cose, a partire dal fatto che i democratici di Biden vincono come “partito” delle istituzioni (e quindi della continuità nonché della prevedibilità, di contro ad un Trump che ha giocato a lungo il ruolo dell’outsider). Contrariamente a quanto molti europei pensano, difficilmente ciò potrà essere ascritto alla forza dei movimenti di piazza, a partire da quelli antirazzisti. I quali invece presentano una natura reattiva, e scarsamente coalizzante, piuttosto che una capacità propositiva. Rispondono alla divisività di Trump, essendone in qualche modo obbligati, ma non è facile credere che siano l’alba di un vero mutamento politico. Molti americani che hanno votato per i democratici, infatti, chiedono di ripristinare una continuità istituzionale che invece percepiscono come lesa dalle effervescenze e dalle intemperanze del candidato repubblicano. Biden parla adesso di «ricucitura», sapendo che un segmento di elettorato gli viene dalla fronda repubblicana, alla ricerca di una figura mediana e non di frattura. Ed è questo l’indice vero del sospiro di sollievo con il quale un’ampia fascia di osservatori ha raccolto l’esito delle elezioni: non la proposta di qualcosa di inedito ma la neutralizzazione di un soggetto visto come potenzialmente pericoloso per gli equilibri istituzionali vigenti. A ben vedere, c’è più domanda di “conservazione” tra gli elettori democratici che tra quelli repubblicani rimasti fedeli al loro candidato. Proprio perché Trump ha raccolto il testimone di un radicalismo che intende trasformare, se non sovvertire, i dati della realtà. Un radicalismo di destra, va ripetuto, ben oltre la stessa tradizione repubblicana, che ha invece colonizzato e piegato a proprio beneficio.
Due considerazioni a latere, a questo punto: la prima è che storicamente, nelle elezioni presidenziali americane, l’adulterazione del voto ha inciso in misura non decisiva nei risultati finali. Discorso a sé rimane semmai il contenzioso tra George Bush jr e Al Gore nelle elezioni del 2000. Quando il secondo chiese il riconteggio dei voti in Florida (dove l’avversario aveva vinto con meno dello 0,5% dei voti), la Corte suprema, con una maggioranza di 5 membri favorevoli e 4 contrari, dichiarò che non fosse possibile procedere alla conclusione del riconteggio delle schede entro la data limite del 12 dicembre, assegnando quindi d’ufficio la vittoria a Bush e permettendogli di ottenere i 25 grandi elettori dello Stato (per la cronaca, quest’ultimo divenne presidente con un solo grande elettore in più della soglia di maggioranza di 270 elementi).
La seconda considerazione da aggiungere è che in quattro anni del mandato di Trump è mutata in modo decisivo la composizione di un organismo strategico come la Corte suprema federale, pendendo adesso decisamente a favore della componente conservatrice, così come diversi giudici della medesima estrazione sono stati nominati un po’ in tutti gli Stati. La qual cosa, nel complesso ma strategico meccanismo dei pesi e dei contrappesi istituzionali, i Checks and balances («controllo e bilanciamento reciproco»), darà corso ad una serrata dialettica conflittuale tra poteri federali e articolazione interstatale delle magistrature. La lotta giurisprudenziale in un sistema di Common Law è fondamentale quanto quella politica e, in tutta plausibilità, costituirà il punto di partenza dal quale i repubblicani si muoveranno per contrastare i passi della futura amministrazione Biden.
In altre parole, esauritosi il periodo di transizione, avendo il nuovo presidente giurato (al netto di eventuali colpi di scena da consumarsi nel mentre, che però allora interverrebbero generando una gigantesca crisi istituzionale) l’inquilino della Casa Bianca dovrà comunque lavorare su diversi piani, a partire dalla esacerbata divisione che attraversa il Paese insieme al tema che ha fatto da sfondo alla campagna elettorale, essendo stato affrontato con due approcci esattamente antitetici, ossia gli effetti della pandemia di SARS-CoV-2. Saranno probabilmente queste le prime mosse, peraltro partendo da posizioni centriste, istituzionali, posto che Biden è un uomo di establishment e si identifica con esso, avendo abilmente dribblato le trappole che, di passo in passo, Trump ha cercato di tendergli. C’è forse un aspetto positivo ed è il fatto che non si presenti come l’uomo delle grandi promesse o delle accese speranze, quale invece era – nell’immagine, ben più che nella sostanza – Barack Obama: troppe attese, infatti, rischierebbero di inficiare da subito le possibilità di ricostruire un ragionevole percorso politico che non è la premessa di questa nuova presidenza ma l’obiettivo nel quale dovrà adoperarsi di qui ai prossimi anni.
Torinese del 1964, è uno storico contemporaneista di relazioni internazionali, saggista e giornalista. Specializzato nello studio della Shoah e del negazionismo (suo il libro Il negazionismo. Storia di una menzogna), è esperto di storia dello stato di Israele e del conflitto arabo-israeliano.

Io non so come quest’uomo riesca a scrivere così bene? Ipnotico, forbito, chiaro, deciso, coerente. Se esiste un dio che benedica Claudio Vercelli.