
La recensione del libro di Stefano Massini, “Eichmann. Dove inizia la notte”
Si può parlare male di un libro scritto bene, pieno soprattutto di buone intenzioni e unanimemente lodato per la sua forza? Mi riferisco all’opera da poco pubblicata di Stefano Massini, intitolata Eichmann. Dove inizia la notte (Fandango Libri, 2020). L’atto unico mette in scena un dialogo inventato fra Adolf Eichmann, il famoso criminale nazista processato e condannato a morte in Israele nel 1962, e la filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt, che dopo aver assistito al processo come inviata del New Yorker ha scritto l’importante e dibattuto libro Eichmann a Gerusalemme (1963), a cui aveva aggiunto quel sottotitolo significativo e foriero di molte incomprensioni e di molte polemiche, che nella traduzione italiana è diventato poi il titolo dell’opera: “Resoconto sulla banalità del male”.
Questo dialogo non solo non è mai avvenuto, ma non avrebbe mai nemmeno potuto aver luogo. Per essere tale, un dialogo presuppone infatti il riconoscimento reciproco delle posizioni dei dialoganti, mentre Hannah Arendt ha sottolineato nella sua opera ripetutamente la sconvolgente stupidità di Eichmann, che si esprimeva ricorrendo continuamente a cliché e frasi fatte, per coprire in tal modo la sua assoluta mancanza di empatia e più in generale la sua incapacità di pensare. Per questo motivo, afferma esplicitamente Hannah Arendt, “comunicare con lui era impossibile, non perché mentiva, ma perché le parole e la presenza degli altri, e quindi la realtà in quanto tale, non lo toccavano.” Chi ci rimette da questo dialogo inventato è dunque naturalmente la filosofa tedesca, che deve addirittura sentirsi dire dal suo interlocutore: “Quanto è ingenua, lei, Hannah. Si vede che a quello che dice crede davvero”. Tanto le domande che i ragionamenti fatti dal personaggio inventato non sono all’altezza né della filosofia della Arendt reale né del suo resoconto-inchiesta sul processo di Gerusalemme.
È fondamentalmente sbagliata, innanzitutto, la questione di fondo che secondo Massini motiverebbe la disponibilità al dialogo della Arendt, vale a dire la sua volontà di comprendere “dove comincia – e perché comincia il male”. In realtà il libro della filosofa tedesca non contiene una sola riflessione sull’origine o sulla natura del male e nell’Appendice dello stesso ella afferma anzi esplicitamente che il suo libro non aveva voluto assolutamente essere “un trattato teorico sulla natura del male”, bensì piuttosto una riflessione sulle premesse, le finalità, le modalità e l’esito del processo. D’altra parte, se la Arendt si fosse servita dell’esempio del criminale nazista per interrogarsi sull’origine e sulla natura del male, ella avrebbe contraddetto uno degli assunti fondamentali del suo libro, che si rifiutava appunto di vedere in Eichmann l’incarnazione stessa del male, rappresentandolo invece come un grigio burocrate e un “carnefice da scrivania”. Proprio questa contraddizione rimane invece irrisolta nel testo di Massini, che da una parte segue molto da vicino il testo della Arendt nel caratterizzare Eichmann come uomo mediocre, che pur non sopportando la violenza e non odiando gli ebrei aveva contribuito, per puro senso del dovere e in seguito alla sua smodata ambizione, allo sterminio di milioni di ebrei, dall’altra pretende di ricavare dal caso specifico del criminale nazista delle risposte alla questione metafisica della natura e dell’origine del male.
Non solo il testo non riesce a rispondere a questa domanda, che occupa la riflessione filosofica da migliaia di anni, ma le argomentazioni formulate mostrano soprattutto quanto possa essere pericoloso porre questa domanda in riferimento alla Shoah. Non è un caso che già nelle prime pagine Hannah Arendt prenda le mosse da un fatto avvenuto in Russia nel 1933, allorché migliaia di contadini senza terra e di criminali vennero confinati su un’isola in mezzo a un fiume in Siberia, senza cibo e senza acqua, affinché morissero di fame e di sete o cominciassero addirittura a mangiarsi a vicenda. E Eichmann risponde a questo racconto narrando a sua volta di una violenza gratuita di un carceriere nei confronti di una lucertola. Tanto Eichmann che la stessa Arendt riportano poi nel corso del loro dialogo numerosi esempi di violenze gratuite che costellano la storia dell’umanità, spaziando dalle uccisioni dei kulaki da parte di Stalin, ai bombardamenti sulla popolazione civile a Plaza de Mayo, a Buens Aires nel 1955, per risalire ai crimini compiuti nelle colonie inglesi, dagli spagnoli in Sud America o ad Haiti, dagli Americani, che con gli indiani fecero “peggio di Mauthausen”, fino alle minacce della guerra fredda ecc. Rifacendosi a una religiosità vagamente panteistica, Eichmann attribuisce la violenza e il male addirittura a Dio ovvero alla natura, ricordando anche le epidemie di peste, il colera e la lebbra che da sempre hanno afflitto l’umanità. Ma è evidente che simili argomentazioni servono solo a giustificare la sua stessa posizione, poiché mostrano come il male sia da sempre una costante nella storia dell’umanità e una presenza inevitabile nella natura, permettendogli di sentirsi in tal modo uno strumento della natura stessa.
È pur vero che la Arendt sembra accorgersi, nel testo di Massini, della strategia autoassolutoria di Eichmann e ribadisce per questo in più occasioni il principio di responsabilità dell’individuo, delle sue scelte e delle sue decisioni, ricordando ad esempio ad Eichmann la resistenza al nazionalsocialismo e il sacrificio dei fratelli Scholl a Monaco. Nemmeno questo richiamo alla responsabilità individuale riesce tuttavia a riportare il male della Shoah alla sua specificità e unicità storica, facendolo apparire quale frutto di un determinato momento storico e di una precisa ideologia criminale. La stessa immagine formulata dalla Arendt in chiusura del dialogo, che riprende non a caso il titolo dell’opera, suggerisce anzi piuttosto che il male sia un evento naturale, simile all’improvviso oscurarsi del cielo al tramonto, con l’avvento della notte.
Al di là di queste implicazioni per così dire metafisiche, è necessario chiedersi se l’immagine di Eichmann quale rotella quasi inconsapevole all’interno dell’ingranaggio dello sterminio sia ancora attuale e abbia una sua funzione o una sua ragion d’essere. Le indagini storiche più recenti hanno infatti definitivamente sfatato l’idea di Eichmann come esecutore “banale” dello sterminio. Nel suo libro intitolato La verità del male. Eichmann prima di Gerusalemme (2017), la filosofa tedesca Bettina Stangneth ha mostrato in maniera inequivocabile come la Arendt fosse caduta nella trappola tesa dallo stesso Eichmann, il quale durante il processo di Gerusalemme si era nascosto dietro la maschera del banale burocrate e del semplice esecutore di ordini. Analizzando le cosiddette “carte argentine”, vale a dire tutti gli scritti prodotti da Eichmann durante il periodo da lui trascorso in Argentina, dove si era trovato al centro di una ricca rete di rapporti e aveva partecipato attivamente a numerosi incontri tra rifugiati nazisti, la Stangneth dimostra come il ruolo svolto da Eichmann all’interno della macchina genocidiaria sia stato ben più importante di quello di una semplice “rotella” e come le sue azioni fossero motivate tanto allora che anche dopo la guerra da un convinto e profondissimo antisemitismo.
Ovviamente nessuno dovrebbe più prescindere da queste conoscenze scrivendo oggi su Eichmann. Ma poiché un’opera letteraria non è e non vuole essere un’opera storica, ci si deve chiedere quale potrebbe essere la funzione di una ripresa letteraria, a quasi sessanta di distanza, delle tesi formulate da Hannah Arendt. Attraverso l’idea della “banalità del male” la filosofa tedesca aveva voluto opporsi a chi considerava i criminali nazisti dei “geni del male”, dei mostri di ferocia, violenza e perversione, dai quali il cittadino comune poteva fin troppo facilmente prendere le distanze, senza sentirsi coinvolto dai loro crimini. La dimostrazione, invece, che anche i crimini più efferati potevano venir compiuti da persone “normali” o addirittura “banali”, da buoni padri di famiglia, da funzionari solerti, magari anche da amanti della letteratura e dell’arte, doveva servire a scalfire le difese e le certezze dell’uomo qualunque, a farlo riflettere sulla sua posizione, sulle sue fragilità ed eventualmente sulle sue responsabilità. Già nel 1964, il filosofo Günther Anders aveva cercato di fornire una spiegazione filosofica più profonda dell’atteggiamento di Eichmann, considerandolo come espressione del “dislivello prometeico”, vale a dire dell’incapacità dell’uomo moderno di prevedere le conseguenze dei propri atti e dei propri progetti nell’era della tecnica, in cui la macchina si è resa autonoma e l’uomo è diventato un suo strumento. Il drammaturgo tedesco Heinar Kipphardt aveva poi applicato queste idee nel dramma documentario intitolato Bruder Eichmann (Fratello Eichmann, 1983), che si basava sui verbali degli interrogatori a cui il criminale nazista era stato sottoposto prima del processo di Gerusalemme, per rendere evidente come l’“atteggiamento Eichmann” fosse più in generale quello dell’“uomo funzionale”, del funzionario, del burocrate o del dipendente che delega la sua coscienza a chi dà gli ordini. Soprattutto nelle cosiddette “scene per analogia”, che crearono grande scandalo e furono oggetto di feroci critiche, Kipphardt mostrò le conseguenze di questo “atteggiamento Eichmann” in altre situazioni della storia contemporanea che vanno dal lancio della bomba atomica fino alla guerra in Vietnam, al conflitto israelo-palestinese o alla lotta al terrorismo.
Indipendentemente dalla sua corrispondenza con la realtà storica, l’interpretazione data dalla Arendt della figura di Eichmann ha avuto dunque una propria legittimità e ha condotto soprattutto a sviluppare nuove categorie per l’interpretazione della realtà. Non vi è dubbio che anche Massini, seguendo da vicino il testo e la prospettiva di Hanna Arendt nella ricostruzione delle vicende biografiche e nella caratterizzazione psicologica di Eichmann, abbia inteso coinvolgere il più direttamente possibile il lettore o lo spettatore. Egli non si attiene tuttavia fino in fondo a questa visione di un Eichmann banale, insignificante e “stupido” esecutore, quando riporta ad esempio le sue parole sul ruolo da lui svolto durante la famigerata conferenza nella villa sul Wannsee, a sudovest di Berlino, dove nel gennaio 1942 venne sviluppata in termini operativi l’idea della “soluzione finale della questione ebraica”. Eichmann racconta, infatti, che a quella riunione non solo aveva partecipato “tutto il governo […], il vertice più alto dell’intera Germania”, ma che vi aveva preso parte persino Hitler in persona, il quale aveva ascoltato con attenzione il discorso tenuto in apertura da Eichmann, annotandosi cifre e pregando i vicini di non disturbarlo. La realtà storica è molto diversa, perché nessun rappresentante del governo e tantomeno Hitler aveva partecipato a quell’incontro. Persino la posizione e la funzione di Eichmann fu in quell’occasione molto più defilata, poiché egli non tenne nessun discorso introduttivo, ma si limitò a redigere il verbale della riunione. Pur tenendo conto del fatto che nel dialogo di Massini è l’inaffidabile Eichmann a raccontare i fatti, stupisce comunque che la sua interlocutrice non lo contraddica. Una simile vanteria di Eichmann contrasta inoltre decisamente con la strategia difensiva messa in atto dal personaggio storico durante il processo, tesa a minimizzare e relativizzare la sua importanza e il suo ruolo all’interno del progetto genocidiario. Si ha dunque la netta impressione che Massini si sia fatto prendere la mano e sia stato trascinato ad allontanarsi così platealmente dalla verità storica dalla volontà di introdurre qualche elemento ad effetto.
Ma anche prescindendo da queste forzature, è necessario porsi in conclusione una domanda fondamentale: non sarebbe stato più utile, proprio oggi, di fronte alla sempre più preoccupante reviviscenza dell’antisemitismo, servirsi della figura di Eichmann per mostrare, sulla base delle nuove conoscenze storiche acquisite sul personaggio, quali siano state le conseguenze catastrofiche dell’ideologia nazista e dell’antisemitismo, invece di rispolverare il cliché ormai superato della banalità del male e perdersi in vaghe considerazioni metafisiche?
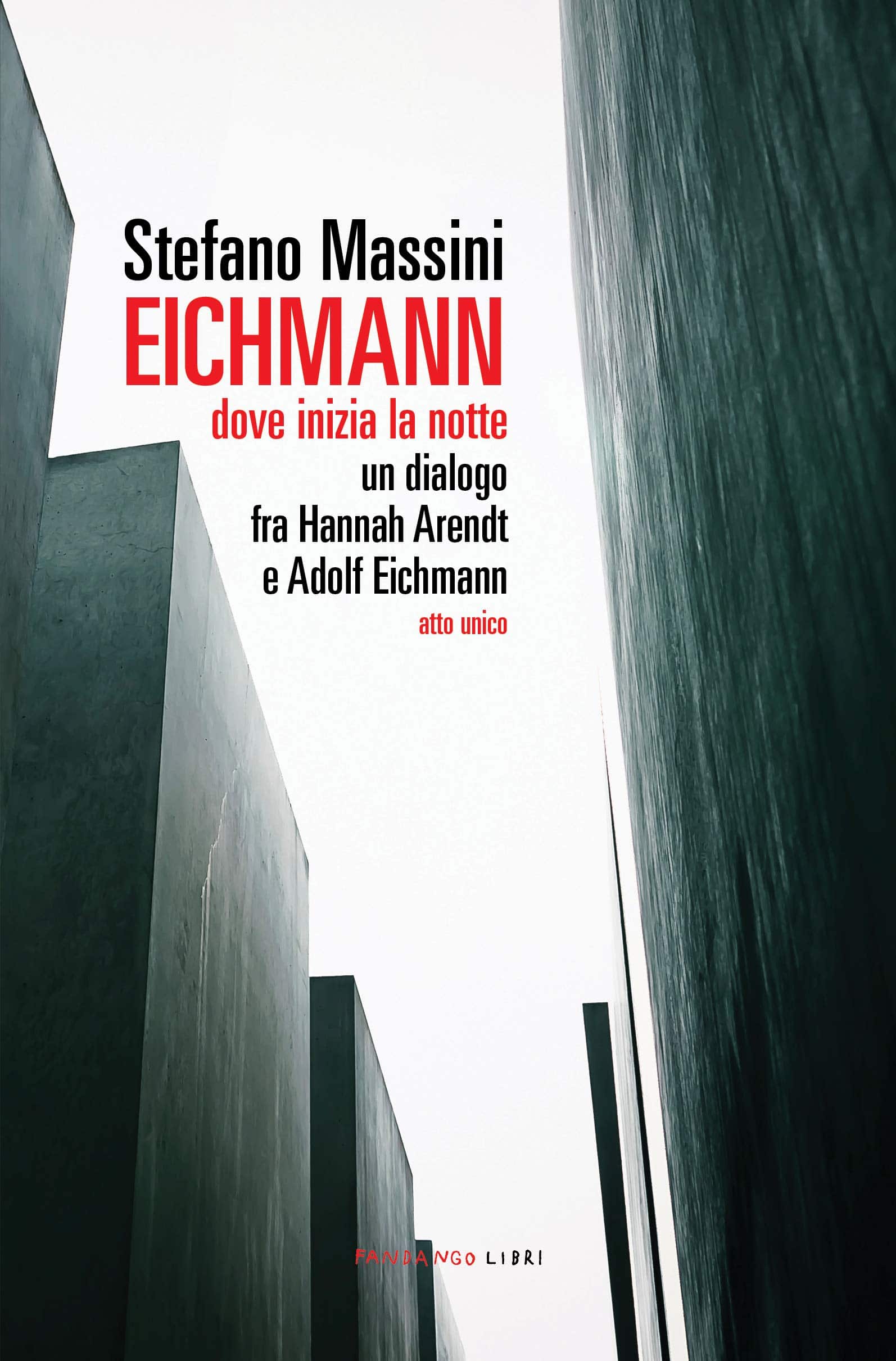
Nato a Bolzano nel 1959, si è laureato a Venezia nel 1984 e ha poi studiato alla Freie Universität di Berlino. Dal 1999 insegna presso l’Università Statale di Milano, dove è professore ordinario dal 2008. Negli ultimi anni ha approfondito il problema della rappresentazione della Shoah e il rapporto tra poesia e filosofia e tra filosofia e teatro. Di recente ha pubblicato Ladri di identità, Mimesis Edizioni.
